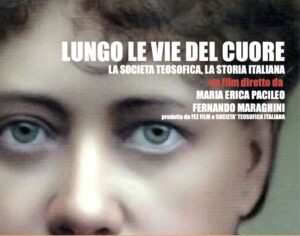C’è un momento, nella vita di chi fa arte, in cui la scena smette di essere solo un palcoscenico e diventa una piazza, un’aula, un campo di battaglia gentile. È da qui che nasce “Chiamata alle Armi Arti”, un titolo che non evoca la guerra, ma la mobilitazione delle coscienze. Una chiamata collettiva a usare l’arte come strumento di trasformazione, come gesto civile.
Nel cuore di Roma, il Teatro Trastevere e la Compagnia Walden rispondono a questa chiamata con un progetto che da tre anni unisce estetica e impegno, parola e azione, riflessione e partecipazione. È “La Città di Tutti”, un festival che cresce di edizione in edizione, portando nelle scuole, nelle strade e nei teatri un messaggio che attraversa i confini dell’arte: la pace si impara, si costruisce, si recita e si vive insieme.
Abbiamo intervistato Antonia Fama.

Antonia, “Chiamata alle Armi Arti” è un titolo fortemente evocativo. Cosa rappresenta questa chiamata e come nasce l’idea di unire arte e impegno civile in un unico progetto?
Teatro Trastevere e Compagnia Walden lavorano da tempo tenendo insieme arte e impegno civile, ancora di più da quando è nata La Città di Tutti, che ci ha dato la possibilità di tradurre in azione concreta quello che era un nostro sogno: fare del teatro uno strumento educativo.
La Città di Tutti è giunta alla terza edizione. Come è cresciuto questo festival nel tempo e in che modo si è trasformato il suo messaggio?
Abbiamo iniziato tre anni fa parlando di inclusione. L’anno scorso ci siamo occupati di diritti umani. Quest’anno di pace e di conflitti. Un filo che non si spezza e che ci riporta sempre al tema principale: la possibilità di offrire la propria arte, le proprie competenze teatrali, come strumento per andare oltre l’estetica.
Quest’anno il tema centrale è la pace. In un momento storico segnato da conflitti e tensioni, come può il teatro – e più in generale l’arte – diventare uno strumento concreto di pace e dialogo?
“L’arte non è mai solo per l’arte”, deve avere la forza di performare non solo sulla scena, ma anche fuori. Per esempio, per la parte di attività dedicata alle scuole, in queste settimane stiamo incontrando decine di ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Per molti di loro progetti gratuiti come il nostro sono davvero una risorsa inaspettata.
Il programma intreccia linguaggi diversi: poesia, stand-up comedy, teatro canzone, laboratori per bambini. Come avete scelto questa varietà di forme artistiche per trasmettere il vostro messaggio pacifista?
Se vuoi parlare a tante persone, devi scegliere per ognuna il linguaggio che è capace di comprendere, e di “sentire”. Mai partire dal presupposto di essere universali, sarebbe presuntuoso pensarlo.
Il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, in particolare con “La Strada dei semi di Pace”, è un elemento chiave. Quanto è importante per voi educare alla pace fin dall’infanzia attraverso il gioco e la creatività?
Non è solo importante, è la chiave di tutto. La Strada Scolastica di via Monte Ruggero, è il frutto dell’impegno degli attivisti di Street for Kids e delle famiglie del quartiere. L’idea che una strada possa diventare una piazza, dove i bambini giocano e le famiglie si ritrovano, risponde perfettamente alla nostra idea di cosa sia il teatro.

Sabato 1° novembre porterai sul palco la stand up “Make Laugh Not War”. Ridere e riflettere insieme: quanto è difficile mantenere questo equilibrio quando si affrontano temi così delicati?
Certo, di fronte a un genocidio c’è ben poco da ridere. Ma quello che si può sempre fare è ridere del potere, farsi beffa di un certo contesto socio-politico, dire a tutti che il re è nudo. Fare battute su chi è fragile è deridere. Farle su chi è forte è comicità.
Il festival vanta la collaborazione con l’Assemblea Capitolina e associazioni come Cittadinanzattiva. Quanto conta oggi creare reti tra artisti, istituzioni e realtà civiche per costruire una cultura condivisa della pace?
Fare rete con altre realtà culturali e sociali è l’unica via per crescere. Sono queste realtà a sopperire sempre più spesso alle lacune educative e strutturali dello stato sociale.
Guardando al futuro, cosa sogni per “La Città di Tutti”? Quale seme di questa edizione speri possa davvero germogliare e lasciare un segno nella città e nelle persone?
Spero di cuore che negli anni questo festival diventi un appuntamento fisso per il pubblico, per le famiglie e per le scuole. Il mio augurio è di continuare il lavoro intrapreso in questi mesi anche dal 3 novembre in poi, quando la terza edizione sarà ufficialmente chiusa.
Alla fine, ciò che resta di questa “chiamata alle arti” non è solo l’applauso o la luce che si spegne sulla scena. È la consapevolezza che un gruppo di artisti, insegnanti, bambini, genitori e cittadini può davvero cambiare qualcosa, anche solo per un istante, anche solo in un quartiere.
Perché fare teatro – nel senso più autentico – significa mettere in scena la vita e dare voce a chi non ce l’ha.
E se il mondo là fuori continua a dividersi, il sogno di “La Città di Tutti” è quello di unire: con una risata, una poesia, una storia raccontata sottovoce.
Da questa terza edizione germoglia un seme di pace che non vuole essere simbolico, ma reale. Un seme che, come ogni atto d’amore civile, chiede solo di essere coltivato — insieme.